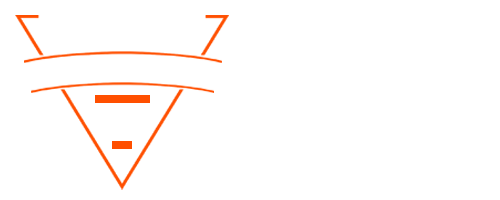LA LIQUIRIZIA DI CALABRIA, Il CONCIO LONGO E LA CONTRADA PESCHIERA
Di Ascus Folk : Quando si parla di liquirizia, si parla di Calabria. La liquirizia di Calabria è il simbolo del Made in Italy nel mondo, è uno di quei prodotti che non temono confronti, aromatizzata o pura, la liquirizia calabrese fa sfoggio di sé da New York a Dubai, “regina” di aeroporti e stazioni. Grazie all’universale attestazione di superiorità, gli estratti calabresi sono i più puri, quelli lavorati con maggior cura, quelli più gradevoli al palato e dotati delle migliori capacità curative e per questo nel 2011 il prodotto ha ottenuto dall’Unione europea il riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta. La Calabria, tuttavia, non è stata una pioniera nella lavorazione e nel commercio di questo prodotto. Le fonti dell’antichità infatti, parlano anzitutto della Grecia e dell’attuale Turchia. Solo nella seconda metà del Seicento, gli intermediari napoletani, spinti dalle crescenti richieste dei loro clienti olandesi e inglesi, riescono a trovare alcuni imprenditori calabresi disposti a trasformare l’abbondante radice spontanea locale in estratto. Le fonti storiografiche parlano di inizi incerti e stentati e solo nei primi anni del Settecento le liquirizie calabresi sfondano letteralmente i mercati di riferimento, insieme ai protagonisti della grande avventura: i latifondisti dell’alto Ionio e le maestranze specializzate dei Casali di Cosenza. L’estrazione di succo dalla radice di liquirizia trova un terreno già maturo, in quanto le nuove officine possono appoggiarsi a una tecnologia localmente molto diffusa: quella della produzione di olio d’oliva. “I trappiti oleari”, gli antichi frantoi, costituiscono infatti il modello di riferimento per organizzare i conci di liquirizia, le officine per l’estrazione del succo. Il “Concio” è organizzato attorno ad un unico grande edificio con un ampio cortile nel quale vengono accatastate le radici, la legna da ardere e il legname per confezionare gli imballaggi; all’interno, avvengono il taglio e lo sminuzzamento della radice e la molitura che trasforma le radici tagliuzzate in una pasta; al centro dell’edificio si trova il torchio dove dalla pasta si ottiene il succo di liquirizia che viene successivamente avviato alla bollitura. Nella produzione della liquirizia la bollitura rappresenta la fase cruciale e la più delicata da cui si ottiene, per l’evaporazione dell’acqua in eccesso, la pasta di liquirizia. È in questa fase finale che diventa determinante la competenza delle maestranze e si decide della qualità del prodotto. Infine, ci sono i locali in cui le biglie – cioè le barrette cilindriche di estratto – vengono sagomate a mano e confezionate e successivamente depositate in casse di legno per le spedizioni. Per sei mesi l’anno, da novembre-dicembre fino a maggio, uomini e donne lavoravano duramente giorno e notte. Ogni concio era un cosmo a sé stante, impiegava gente addetta alle mansioni più disparate tanto da dare l’idea di un vero e proprio centro abitato. Tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, nella provincia di Cosenza erano operative 9 fabbriche di liquirizia. Ben tre erano a Corigliano, di proprietà del principe Nicola Gaetani, del barone Francesco Compagna e di Guglielmo Tocci e impiegavano 193 operai. A Rossano erano presenti le fabbriche di Giuseppe Amarelli, che da sola dava lavoro a 66 operai, di Giuseppe Martucci e di Gennaro Labonia. A Cerchiara era attiva la fabbrica del principe Pignatelli, a San Lorenzo del Vallo quella di Giulio Longo e a Rende quella di Tommaso Zagarese. Oggi il paesaggio calabrese è punteggiato di conci dismessi che formano un importante patrimonio di archeologia industriale. Il solo concio storico ancora in funzione è quello degli Amarelli a Rossano. Gli altri, riconvertiti o diroccati, si stagliano ancora imponenti in molte località.
Il “Concio Longo” o “Concio Peschiera” nacque intorno al 1839, in contrada Peschiera a San Lorenzo del Vallo, come concio di liquirizia ad opera della famiglia Longo, una famiglia di imprenditori puri, non appartenenti a casati di proprietari latifondisti, provenienti da Casole Bruzio. I Longo acquistarono dagli eredi della Marchesa Della Valle tutti i possedimenti e l’universum jus del feudo. Intorno al 1880 la fabbrica si ampliò tanto che la fattoria divenne un piccolo villaggio rurale, con scuola e chiesa (la cappellina di San Giorgio), dove vivevano le famiglie degli operai, e fu uno dei pochi stabilimenti che utilizzava l’energia idraulica per la macerazione della radice, ancora è visibile e in discreto stato di conservazione la vecchia condotta dell’acqua. Grazie all’alta qualità del prodotto, la fama dell’azienda superò i confini Nazionali, la liquirizia veniva esportata nel Nord Europa ma soprattutto in Francia e Inghilterra dentro eleganti scatole con la graziosa scritta “dulce meum tegìt terra” (la terra nasconde la mia dolcezza) ed era talmente conosciuta da essere citata nell’Enciclopedia Britannica. Agli inizi del 1900 Luigi Longo e la moglie Virginia Bombini di Giuseppe (nata a Cosenza 19 agosto 1888), sposati il 4 aprile 1910, ereditarono l’azienda e la gestirono con grande tenacia e forza per oltre 60 anni, attraversando due Guerre Mondiali. L’azienda agricola allora aveva una cospicua estensione di ettari dove si sviluppavano diverse coltivazioni ed allevamenti, tra cui l’allevamento del baco da seta. Inoltre, le foreste circostanti fornivano legname per le industrie marittime del Nord Italia. Dopo la seconda guerra mondiale il governo espropriò i proprietari terrieri riducendo così l’estensione dell’azienda agricola. Negli anni ’70 la nipote Virginia Bombini jr, insieme al marito Fernando Gallo, subentrarono nella gestione dell’azienda agricola rinnovandola profondamente. Bonificarono i terreni incolti e piantarono nuovi frutteti, uliveti e vigneti. I vigneti, antica tradizione di famiglia, comprendono tutti vitigni autoctoni e tipici del territorio: Magliocco, Aglianico, Mantonico, Pecorello, Greco, Moscato. Oggi i vini dell’azienda, che vantano il marchio Terre di Cosenza D.O.P. sono due rossi: “Siamisi” e “San Lorenzo”, un bianco: “Jentilino” e un rosato: “Abbaruna”, nomi emblematici per il territorio di San Lorenzo del Vallo. Oggi La Peschiera è un’azienda agricola, con annesso B&B, gestita dal figlio Alessandro Gallo che, insieme alle sorelle Daniela e Flaviana, ne curano la produzione.
Credits: Prof. Cosimo Scorza (Spigolature storiche su San Lorenzo del Vallo, Ed. MIT 1971) – Lapeschiera .net – Wikipedia – ICalabresi.it